Come molti chef, ho una questione in sospeso con due elementi che ci appartengono quanto la giacca e il toque da chef, ovvero l’adrenalina e la dipendenza. Penserete al più banale abuso di sostanze chimiche, sintetiche, all’abuso di alcol, all’erotomania o a qualche particolare pratica connessa al mondo sadomaso. O ancora che si tratti di tutte queste possibilità intersecate una all’altra, un gomitolo di debolezze subumane che si aggrovigliano deteriorando il corpo e invecchiando il viso di una buona decina d’anni.
Siamo tutti carichi delle pressioni che ci rendono fragili, figuratevi se possedete un rinomato ristorante in un paesino sulle rive del lago Maggiore, magari all’interno di una villa storica dei primi del Novecento, con un parco di quattromila metri quadri di ars topiaria e alberi secolari, se siete stati insigniti di ben quattro stelle Michelin e se hanno scritto della vostra cucina nelle principali testate giornalistiche mondiali. Figuratevi poi se conducete tre programmi televisivi di cucina, e in un altro siete uno dei tre giudici divinizzati; ecco, in questo genere di situazioni le fragilità si trasformano in peccati mortali.
La questione è che io lo bramo da sempre, lo adoro da quando ero ancora nella pancia di mia madre, che forse ne abusava; il fatto è che io amo follemente quello che tutti i miei stellatissimi colleghi chiamano, con l’atteggiamento supponente che li contraddistingue, cibo spazzatura.
Era tutto così semplice quando non ero nessuno. Potevo entrare nei peggiori kebabbari della sponda magra, nelle più squallide pizzerie da asporto, oppure nei sempre affollatissimi fast-food della provincia, senza che nessuno se ne accorgesse o facesse caso alla mia presenza a dir poco ingombrante.
Da quando sono diventato una celebrità della cucina, tutto è cambiato. Adesso mi tocca adottare particolari travestimenti o trucchetti per cercare di non essere rintracciato o avvistato mentre divoro qualche sottoprodotto culinario di sordida fattura.
Mi capita di farlo dappertutto e a qualsiasi ora. Mi capita di entrare dal kebabbaro agghindato da motociclista professionista, con tanto di casco integrale e di ordinare una piadina falafel con salse, patatine e la bibita gassata più zuccherosa che esista sul mercato.
Non posso permettermi che qualcuno mi veda e scopra questa mia passione perversa. Nessuno deve conoscere questo mio lato; non lo conoscono i miei genitori, i miei amici, la mia compagna e non devono conoscerlo i soci del ristorante: se la scoprissero, perderei ogni credibilità.
A volte, quando finisco di salutare i miei prestigiosi clienti al ristorante, dopo aver supervisionato i piatti deliziosi e striminziti che escono dalla cucina di centocinquanta metri quadri, allungo la strada verso casa e mi fermo dal lurido di Mario, che è sempre posizionato ai lati di una rotonda di passaggio.
Giuro che ci provo a non allungare la strada, ma la mia auto sportiva mi guida verso quel maledetto furgoncino illuminato, dove Mario fabbrica i panini con la salamella più unti del mondo.
Di solito, per non destare sospetti, quando mi fermo da Mario parcheggio di nascosto a un centinaio di metri, mi cambio e indosso una divisa da vigilante che ho comprato dai cinesi, a dieci euro, il Carnevale passato. Così, mi imbosco poco prima di arrivare alla rotonda e mi cambio in fretta e furia per cercare di raggiungere il prima possibile un panino trasudante di ogni grasso possibile.
Ogni volta che lo addento avverto una scossa di adrenalina che nessun’altra droga sarebbe in grado di darmi. Al secondo morso mi sento un ribelle, un rivoluzionario che sta lottando per la liberazione, una sorta di presa della Bastiglia nei confronti della propria morale stomachevole e reazionaria.
C’è poi il momento in cui Mario e i soliti clienti mi chiedono come stia andando il turno di vigilanza.
«Da Dio», gli rispondo io sorridendo, con la salsa tra i denti e sulla barba. Poi, mentre mi lecco i baffi per la goduria, comincio ad alimentare le credenze sul mio lavoro di vigilante per supportare la mia seconda vita.
Capita che qualcuno mi si avvicini, mi osservi con cura, con un morso del panino unto in bocca, e mi dica di avermi visto da qualche parte o addirittura di assomigliare molto a un celebre chef della televisione. Pronunciano il suo nome, il mio nome, scandendolo come se fosse una creatura mitologica, impossibile da avvicinare e ancora meno da scovare in un posto squallido come il lurido di Mario. In quel momento mi scorre in tutto il corpo un brivido sottilissimo, pari soltanto agli anelli di cipolla fritti di un noto fast-food.
Non appena finisco il panino, pago, porgo il pugno a Mario per ringraziarlo della godereccia schifezza che mi ha rifilato e mi allontano a piedi per raggiungere la mia auto sportiva ben nascosta dietro agli alberi. Poi, mentre guido verso casa, mi sfioro con le dita la barba e i baffi, poi le porto al naso per annusarle e avvertire quel peccato tanto unto che un giorno potrei pagare a caro, carissimo prezzo.
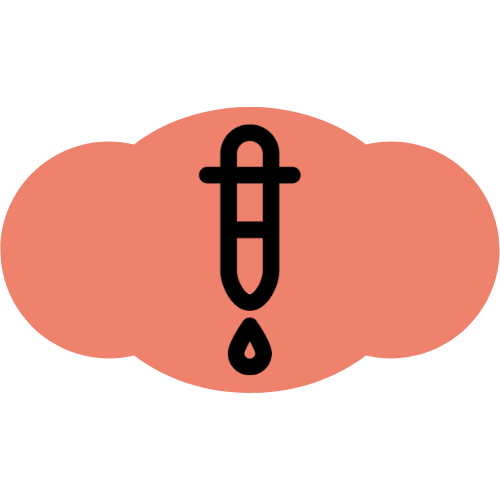 Massimiliano Piccolo (1982) ama passeggiare tra i boschi e viaggiare. Ha pubblicato vari racconti su Pastrengo, Argo, Firmamento, A Few Words, Inutile, Cadillac, Spazinclusi, A-Rivista Anarchica, L’Irrequieto, Crapula, Fillide e altre.
Massimiliano Piccolo (1982) ama passeggiare tra i boschi e viaggiare. Ha pubblicato vari racconti su Pastrengo, Argo, Firmamento, A Few Words, Inutile, Cadillac, Spazinclusi, A-Rivista Anarchica, L’Irrequieto, Crapula, Fillide e altre.
