Entrammo nel bistrot con alle calcagna l’alba, sorella di un pomeriggio che si era allungato al caffè Navarre, tra un whisky e l’altro, mettendo al bando il servilismo accademico e acclamando la rivoluzione che passa per il pennello, «ma comincia dalla cena» aveva suggerito Mangual, aggiungendo «che le imprese a stomaco vuoto se le porta via la bile». Quando mi incontrai con gli altri a pranzo, pensavo ancora che sarei rincasato per le cinque e che nulla quel giorno mi avrebbe distratto dall’iniziare la mia opera. Poi il cognac, i dolci al burro, autentica specialità del Madeline, il sentimentalismo del primo Chopin, LaBrie che usava i quadri della tovaglia come tastiera, poi ancora il cognac e l’ora dell’aperitivo con cui si tornava al concerto per pianoforte in Fa minore. Eppure la tela mi aspettava. Non sapevo ancora cosa avrei fatto, ma l’ansia di grandezza mi stava col fiato sul collo e i pennelli erano secchi da giorni. In compenso l’umore era piuttosto umido, un contributo dell’alcol e delle risate che chiamavano le bollicine; gli altri non si sarebbero fermati per nessun motivo e Mangual aveva deciso di fare da guida barcollante verso ognuna delle mete di cui eravamo clienti abitudinari.
Quando aprimmo un’altra bottiglia di champagne, sedevamo vicino al camino di uno dei pochi bistrot che restava aperto fino all’alba, l’orchestra sul palchetto poco distante aveva attaccato con dei pezzi blues, mentre Mangual attaccava con gli aneddoti che tutti noi della compagnia conoscevamo a menadito, ma che nessuno si sentiva mai in dovere di interrompere.
«Diglielo un po’ Ruge», mi fa. «Diglielo che hai combinato al vecchio trombone durante la sua lezione sugli studi di luce», e guardava gli altri, sgranando gli occhi, come a dire state pronti che questo treno non torna più.
Il vecchio trombone era chiaramente Romero, il professore di pittura, probabilmente c’era rimasta solo la moglie che non lo chiamava così, almeno in sua presenza.
«Ma quella storia del gessetto, dici?», domandai col tono piatto di chi considera la forma di una mattonella.
Annuì entusiasta, contagiando pure LaBrie, Balog e Wallner. «È che il gesso gli fa allergia al vecchio. Forse quando lo tiene in mano lo confonde con le dita, tant’è pallido. Gli ricorderà la tomba, che vi devo dire».
Gli altri ridevano coi loro bicchieri in mano e io riuscii a evitare di raccontare l’intera storia del gessetto e dell’inchiostro di china da capo. Proseguì Mangual al posto mio. Aprimmo un’altra bottiglia, mentre Balog continuò fedele col suo vino rosso, e la casa dello studente si allontanava sempre di più, così pure i miei strumenti. D’altronde eravamo la pattuglia d’avanguardia dell’accademia e le nostre riunioni dovevano essere il meno collegiali possibile. Era tutto pensiero quello lì, attivazione del potenziale tra le poesie figurative di LaBrie, i vermut delle quindici e l’oliva, quel resto estetico di cui Mangual adorava disquisire, le linee del selciato fino alla prossima porta illuminata e le risate di Balog e Wallner; incredibile come due persone possano scannarsi se si tira in ballo la guerra dei trent’anni e suonare con la sincronia della cornamusa e il suo soffietto, quando ridono.
E ridevo pure io, mentre pensavo alla mia opera. Sarebbe stata fuoco puro. Qualcosa di cui all’accademia avrebbero parlato per i giorni a venire: Hai visto che ha combinato Gregorio Ruge?, Un genio assoluto!
M’immaginavo già la mia fama correre rapida, e brindavo segretamente a questo, partecipando e disgiungendomi dall’ennesimo levarsi dei calici: il mio corpo eseguiva il movimento insieme a loro, il bicchiere in alto e il sorriso che seguiva le linee degli altri commensali, lo stesso punto di fuga di una prospettiva comune, i volti scaldati dall’alcol e dal focolare, eppure la testa andava da tutt’altra parte.
Non so come, ma mentre ero lì la mia mente iniziò a navigare e a perdersi. A un certo punto mi trovai a contemplare un quadro di Jean-Georges Vibert. Chissà perché proprio lui? E perché proprio La distrazione, “l’opera minore di un pittore minore”, pensai, mentre sullo sfondo del mio campo visivo uno sfocato Mangual si girava a guardare la cameriera che passava tra i tavoli. E sul volto del mio collega intravidi la stessa espressione di stupore del prete del quadro. Improvvisamente quell’immagine si impose alla mia mente, sovrapponendosi alla realtà che mi circondava, come se ce l’avessi davanti gli occhi: due uomini di chiesa, uno a piedi e l’altro a cavallo con in mano un grosso ombrello rosso, attraversano una strettoia di terreno sconnesso. Da un lato si intuisce la via sdrucciolevole per un fosso, dall’altro una popolana si fa da parte per farli passare. Ma schiacciando la schiena al muro e alzando l’anfora che porta con sé per diminuire la superficie occupata, la giovane ragazza protende il torso in avanti, e il suo petto si alza, diventa la nuova strada per lo sguardo del prete. La distrazione è così dolce, l’afrore delle braccia alzate e lo sguardo della donna catturano il prete, che accidentalmente smarrisce ogni buon proposito. Quasi sembra pensare che non sia neppure peccato, quando si viene colti così di sorpresa.
È in quel momento, cullato dalle risate degli altri due, che mi misi a pensare che fu proprio un monaco dell’undicesimo secolo – il suo nome era Algisio da Sovana – ad avanzare delle teorie sulla distrazione, sul perché gli uomini di ogni tempo ed epoca si trovassero spesso a essere contemporaneamente nella realtà fisica, ma con lo spirito rivolto altrove. Nella sua opera De Dualitate Hominum In Distractione, o perlomeno di ciò che ne è rimasto dopo la sua condanna, Adalgisio sembrava richiamare le teorie orfiche, i riferimenti alla dimensione individuale del sacrificio si distanziavano dalla dimensione collettiva puramente cristiana, soprattutto quando il frate parlava di una dualità dell’uomo tra corpo e anima. Questa tensione, secondo il monaco, caratterizzava l’intera vita dell’uomo ben prima della morte e della separazione dell’anima dal corpo. Perlomeno questo è quel che ci aveva raccontato il vecchio trombone durante una delle sue lezioni per dirci che qualcuno nel medioevo si era addirittura impegnato per descrivere lo stato di cose in cui versavano le nostre menti assenti, mentre lui era lì a spiegarci che l’inchiostro di china non assorbe il gesso e che non saperlo, avrebbe portato ad autentici disastri su tela. Così Romero ci sfotteva, tirando in ballo qualcuno che aveva addirittura cercato di dare una dignità a quello che noi facevamo quotidianamente in classe.
Scoprii, cercando in biblioteca, che gli studi del monaco sulla distrazione proseguirono. Secondo gli studi di Patrick Mitchell sulla figura del monaco, che gli valsero la cattedra di antropologia mistica all’università di Birmingham, Adalgisio da Sovana aveva proseguito le sue indagini sulla distrazione, arrivando a formulare l’ipotesi che tale fenomeno fosse originato dalle vibrazioni che emana l’anima, vibrazioni di un colore scuro e profondo che possono influenzare anche l’ambiente circostante. Nel suo libro Mitchell raccontava anche gli ultimi anni della vita del monaco, che arrivò a progettare l’architettura dei monasteri come edifici di risonanza cosicché le liturgie si propagassero secondo le vibrazioni bianche, evitando quelle oscure. Il nome del testo già mi sfuggiva di mente, eppure ricordavo il frammento citato da Mitchell in cui Adalgisio recitava:
Così come gli uomini non conoscono il regno dei cieli o degli inferi, neppure gli è dato sapere dove vaga l’anima quando il corpo è ancora vivo.
Forse vagare non era il termine giusto, ma un vizio di forma che lo studioso anglofono aveva restituito alla traduzione. È probabile che il prete non intendesse wander, e forse sarebbe stato più corretto dire migrate, altrimenti non l’avrebbero condannato per eresia, tentando di distruggere ogni parte del suo trattato.
Non osai mai dirlo al vecchio Romero, compresi da me che ogni opera deve plasmare la realtà, utilizzarla a suo piacimento per raggiungere i suoi scopi. Occorre prendere ciò che serve e superare il resto, filtrarlo via: è questo che deve fare l’arte, sia questa figurativa, sia quella di impianto saggistico espositivo.
Tornai tra i miei commensali arricchito dal mio viaggio, partecipando d’impulso alla conversazione che in quel momento verteva sulla pittura dal vivo che andava affermandosi in quel periodo. Wallner diceva che la pittura è un’esibizione solo quando è pronta e che quel nuovo tentativo di unire il progetto dell’artista alle emozioni del pubblico presente rischiava di distrarre il pennello dal suo scopo.
«Parliamoci chiaro, è come vendersi», lo appoggiò Mangual. «Non che in altri campi mi dispiaccia. Qualcuno dovrà pur pagarlo questo champagne» disse poi, ridendosela della grossa e assaporando l’ennesimo bicchiere.
Balog, invece, ne faceva un discorso di sostanza delle arti, disse proprio cos: «La pittura non è come la musica», affermò, e lo fece sul ritmo del blues e dei suoi giri armonici, quasi cadenzando le sue affermazioni sul fatto che la pittura necessitasse di ponderazioni e di pause.
Istintivamente portai la mano al blocchetto che avevo in tasca, quasi per tastare con mano la durata, ormai eccessivamente lunga, della mia ponderazione.
«L’arte visiva è fermentazione», aggiunse infine Balog, facendo oscillare il vino rosso nel bicchiere.
Per quanto mi riguarda, io non avevo un’opinione così definita all’epoca, non sapevo bene cosa pensare a riguardo, ma una cosa era certa: loro erano ancora fermi all’ultima moda che, come ogni moda si radica e finisce per dettare gli standard. Quando avrebbero iniziato a piegare il loro interesse alla pittura dal vivo, io l’avrei già assimilata e superata.
Intanto un altro giro di champagne si era reso indispensabile, dovevamo togliere le ultime ore a quella giornata per ucciderla. Eppure in quel momento mi resi conto che dovevo compiere una rottura, non perché credessi di essere ancora in tempo per iniziare la mia opera, ma perché la nostra opera si stava riducendo a questo: un impegno costante per fornire concetti da accompagnare ai calici e alla latitanza notturna. Guardai il parossismo di Mangual, il nostro banditore, e mi resi conto che spiegarglielo non sarebbe servito a nulla. Un altro giro, un altro passaggio della cameriera e Mangual diventava di nuovo quel prete del dipinto di Vibert, che segue la via di quel volto femminile e distoglie lo sguardo dal percorso accidentato. E io lo guardavo come il cardinale a cavallo, esattamente come lui esaminavo la sua disattenzione e lo condannavo non per il gesto in sé ma per la sua natura e le scelte che lo avevano portato a quell’istante.
Mi tornò alla mente la leggenda che girava sulla bocca delle persone, circa un decennio prima, riguardo a un assassino. Ma non un caso qualsiasi di uomo che uccide i suoi simili, non efferatezza, vendetta o odio, bensì un gioco perverso. Il suo caso mi aveva affascinato a tal punto che avevo buttato giù qualche studio per il soggetto – che non realizzai mai, preso dagli studi all’accademia e dalle nostre serate. Non aveva neppure un nome, perché l’assassino non ne aveva; ovviamente non è mai stato trovato o arrestato. La cosa che rendeva complicato indagare su quest’uomo – o donna, a tal punto si ignorava la sua identità – è che costui non commetteva dei delitti consuetudinari. Le sue armi erano il mondo altrui, o meglio, il mondo in cui gli altri vivevano e da cui si alienavano, lasciandosi prendere da un capriccio della mente. Ebbene, l’assassino uccideva per mezzo delle disattenzioni delle sue vittime. Modificava qualcosa dell’ambiente circostante, bastava un dettaglio noto solo alla sua mano e a cui gli altri non avrebbero mai badato, un’alterazione dell’ambiente che costava cara la vita della vittima prescelta. Nessuno ha mai considerato la letalità di un innocente vaso ornamentale leggermente fuori posto sul portone che dà sul crocevia di un piccolo paesino, le circostanze di una telefonata che hanno portato il farmacista, noto usuraio del paese, a ritardare l’attraversamento di quella strada per tornare a casa, come faceva tutte le sere, col suo passo svelto. Tuttavia, alle sedici lo scarrozzare era più intenso, le vibrazioni maggiori, e il malcapitato farmacista provò a evitare la porta che gli si spalancò di fronte all’improvviso, una signora che inseguiva il cagnolino sfuggito, così come la ruota del mezzo in arrivo provò a schivare il vaso in curva, schiacciando sotto il suo peso il farmacista. La morte senza mani, figlia della distrazione: non è la falce a colpire, bensì la vittima ad andare incontro alla lama. E io avrei voluto rappresentare quell’evento, me ne accorgevo solo adesso che l’avevo lasciato scappare via dalla mia mente, perché più lo pensavo e più vedevo una semplice tela con un ambiente urbano e il soggetto che veniva investito. Avrei potuto collocarlo in qualsiasi epoca, nel presente così come nel passato, sarebbe stato comunque slegato dalla sua leggenda. Intanto le persone se ne sono dimenticate, così come hanno dimenticato quel proliferare di teorie riguardanti una società di assassini, gli inattention killers, come li aveva definiti Mitchell, che attribuisce la defenestrazione di Praga del 1618 a una colluttazione, è vero, ma uno scontro che non sarebbe sfociato nella defenestrazione e nella famigerata guerra, se nella sala delle riunioni del castello di Hradčany dove vennero portati i due luogotenenti imperiali, il massiccio scrittoio in legno si fosse trovato come sempre davanti alla finestra e non spostato al centro della stanza.
Me ne rimasi assorto nei miei pensieri, osservando il prete di Vibert che metteva un piede fuori posto, la vibrazione doveva essere esattamente la stessa che udii in quel momento, bassa e dura sul terreno sconnesso, una nota profonda, come di un tavolo pesante che viene spostato. Osservai Mangual gettarsi esausto e felice sulla sedia, la risata che gli riempiva la pancia sotto la camicia di tela, e uno scricchiolio che nessuno notò, un dettaglio sonoro che si perse tra il baccano dei presenti. Solo il mio occhio vide la gamba della sedia inclinarsi in modo scomposto. Di lì a un secondo, il legno cedette al peso, la mia mano divenne un tutt’uno col rumore del tavolo che Mangual cercò di afferrare per non cadere all’indietro. Presi il mio blocco nell’esatto istante in cui la distrazione di Mangual si fece irrecuperabile, la sedia si spaccò, lo sguardo degli altri corse al focolare acceso. La mia matita iniziò a schizzare la bocca aperta della caduta, per poi scivolare rapida verso la cameriera che si gettò terrorizzata con la schiena contro il muro.
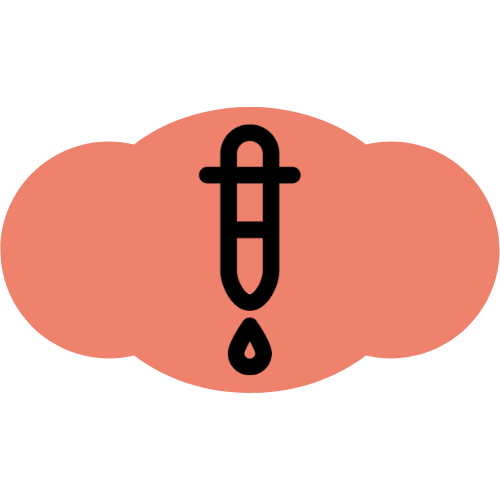 Valerio Russo è nato a Roma nel 1985. Laureato in Filosofia, insegue costantemente il knockout del racconto. Negli ultimi anni si è dedicato alla sceneggiatura per fumetti e la scrittura per immagini è entrata nella sua idea di narrazione. I suoi racconti sono stati pubblicati su Neutopia, Narrandom, E(i)sordi, Blogorilla e inutile.
Valerio Russo è nato a Roma nel 1985. Laureato in Filosofia, insegue costantemente il knockout del racconto. Negli ultimi anni si è dedicato alla sceneggiatura per fumetti e la scrittura per immagini è entrata nella sua idea di narrazione. I suoi racconti sono stati pubblicati su Neutopia, Narrandom, E(i)sordi, Blogorilla e inutile.
